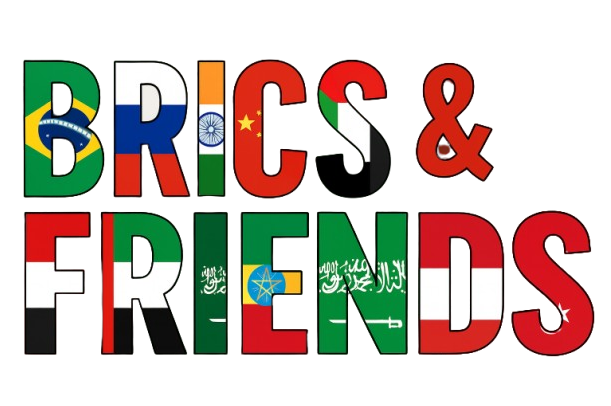A cura di : Amb. Amr Helmy
WASHINGTON D.C. Le recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, così come i segnali che indicano una riduzione della probabilità di un intervento militare diretto contro l’Iran, non devono essere interpretate come la fine della fase di confronto con il regime iraniano. Al contrario, esse appaiono parte di una ricalibrazione strategica degli strumenti di pressione e dei tempi di intervento, maturata alla luce delle lezioni apprese dall’esperienza statunitense in Medio Oriente.

Negli ultimi due decenni, Washington ha progressivamente consolidato la convinzione che il rovesciamento dei regimi dall’esterno non garantisca stabilità, ma produca spesso vuoti di potere, frammentazione istituzionale e conflitti prolungati. In questo quadro, l’opzione militare contro l’Iran non è stata accantonata, bensì rinviata e ridefinita all’interno di una strategia più ampia e graduale.
Dal cambio di regime al contenimento strategico
L’attuale orientamento statunitense sembra privilegiare una strategia di contenimento e logoramento progressivo del sistema iraniano, piuttosto che un obiettivo immediato di cambio di regime. Tale approccio riflette una valutazione centrale: il rischio principale non risiede tanto nella sopravvivenza del regime, quanto nelle conseguenze di un suo collasso improvviso, privo di alternative politiche e istituzionali credibili.
L’assenza di uno scenario chiaro per il “day after” rappresenta uno dei principali fattori di cautela nelle valutazioni strategiche occidentali. Una caduta del regime iraniano non garantirebbe automaticamente una transizione ordinata o democratica; al contrario, potrebbe aprire una fase di instabilità prolungata, con effetti difficilmente controllabili.
Il rischio di un collasso non gestito
L’Iran è un attore sistemico nello spazio mediorientale. Un’implosione non governata dell’autorità centrale rischierebbe di riattivare tensioni etniche latenti tra curdi, azeri, beluci e arabi, oltre ad accentuare le vulnerabilità delle minoranze religiose. In tale scenario, il Paese potrebbe trasformarsi in un polo di instabilità regionale, caratterizzato da conflitti tra attori armati concorrenti e da un progressivo deterioramento del controllo territoriale.
La complessità della struttura sociale iraniana, la profondità storica del suo sistema politico e il radicamento degli apparati di sicurezza e militari rendono qualsiasi processo di disintegrazione una potenziale fonte di instabilità duratura. Le implicazioni sarebbero dirette: minacce alla sicurezza del Golfo, alla stabilità delle rotte energetiche – in particolare nello Stretto di Hormuz – e alla tenuta del regime internazionale di non proliferazione nucleare.
I limiti dell’opzione militare
Un intervento esterno esplicito, sia statunitense sia israeliano, potrebbe inoltre produrre effetti controproducenti. Il regime iraniano potrebbe sfruttare l’attacco per rafforzare la propria coesione interna e rilanciare una narrativa di legittimazione fondata sulla resistenza all’aggressione straniera, consolidando ulteriormente il controllo securitario.
A Washington come a Tel Aviv è diffusa la consapevolezza dei limiti intrinseci della forza militare nel determinare il collasso di un sistema di potere profondamente istituzionalizzato. Le capacità iraniane di deterrenza asimmetrica, l’uso di strumenti ibridi e la possibilità di destabilizzare indirettamente i mercati energetici rappresentano fattori che aumentano il costo strategico di un’azione militare diretta.
Pressione multilivello e deterrenza
Di conseguenza, l’opzione militare appare oggi concepita prevalentemente come strumento di deterrenza e di contenimento del comportamento iraniano, o come leva per interventi selettivi e circoscritti, piuttosto che come via privilegiata per il rovesciamento del regime. La strategia emergente è quella di una pressione multilivello: isolamento politico, inasprimento delle sanzioni economiche e targeting delle capacità critiche del sistema iraniano, in particolare nei settori della sicurezza, dell’intelligence e del dominio cibernetico.
L’obiettivo resta quello di ottenere concessioni sostanziali sul programma nucleare e sulle capacità missilistiche, senza innescare un conflitto regionale su vasta scala. Parallelamente, viene lasciato spazio all’evoluzione delle dinamiche interne iraniane, nella prospettiva che l’accumulo di pressioni conduca il sistema verso una soglia di esaurimento strategico.
Un Medio Oriente in trasformazione
Questo processo si inserisce in un contesto regionale in rapido mutamento. Il progressivo indebolimento dell’architettura di influenza costruita da Teheran negli ultimi quattro decenni – fondata su una rete di attori proxy – ha ridotto la capacità dell’Iran di proiettare potere indirettamente e di assorbire le pressioni esterne. La disgregazione di parte di questo asse ha reso il sistema iraniano più esposto e meno resiliente, pur senza annullarne la pericolosità.
In tale quadro, il rinvio dell’opzione militare non equivale a una rinuncia strategica, ma rappresenta una scelta calcolata: mantenere alta la pressione, evitare il collasso incontrollato e lasciare che il logoramento interno ed esterno riduca progressivamente la capacità del regime di sostenere il confronto. Una strategia di attesa attiva, in cui la forza resta sullo sfondo come ultima ratio, ma non come strumento immediato di soluzione.8
*L’autore è stato Ambasciatore d’Egitto in Italia dal 2013 al 2017. E’ stato membro del Senato egiziano e autore di numerosi articoli a carattere politico, economico e culturale.
@RIPRODUZIONE RISERVATA.