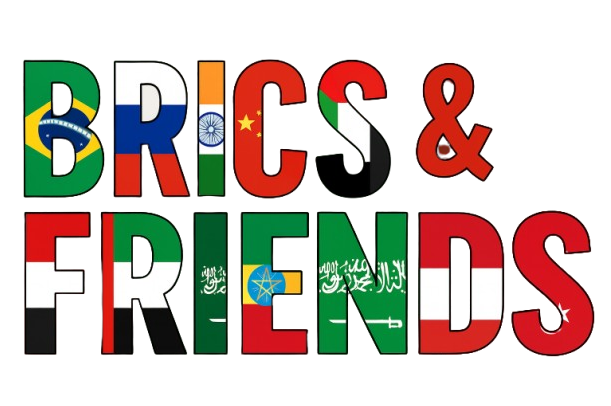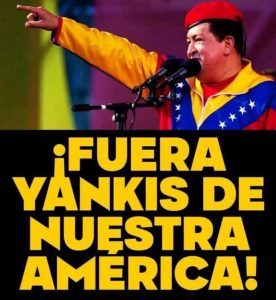
Il caso venezuelano non può essere letto come una semplice crisi nazionale, né come l’ennesimo scontro tra “democrazia” e “autoritarismo”, formula ormai svuotata di significato analitico. Il Venezuela è piuttosto un laboratorio geopolitico, in cui si misurano i limiti reali del potere statunitense in una fase storica di declino relativo dell’egemonia occidentale e di transizione verso un ordine internazionale più frammentato e multipolare.
Da oltre vent’anni il Paese è sottoposto a una pressione sistemica che combina sanzioni economiche, isolamento diplomatico, guerra informativa, delegittimazione giuridica (lawfare) e tentativi più o meno espliciti di rovesciamento del governo. Questa strategia non nasce con Maduro, ma con Chávez, e non è legata alla personalità dei leader bensì a un nodo strutturale: il rifiuto del Venezuela di essere pienamente integrato come periferia obbediente dell’ordine economico e politico guidato dagli Stati Uniti.
La domanda centrale, dunque, non è se Washington “voglia” distruggere il Venezuela, ma se sia oggi in grado di farlo senza produrre effetti collaterali peggiori dei benefici attesi.
La distruzione come processo, non come evento
L’esperienza storica mostra che gli Stati Uniti sono perfettamente capaci di eliminare leader scomodi, favorire colpi di Stato o sostenere guerre civili per procura. Tuttavia, il Venezuela presenta alcune caratteristiche che rendono improbabile una soluzione rapida e “pulita”.
In primo luogo, lo Stato venezuelano – pur indebolito – non è collassato. Le Forze Armate restano un attore centrale, non solo sul piano militare ma anche economico e simbolico. Questo significa che non esiste, allo stato attuale, una frattura decisiva tra potere politico e apparato coercitivo, condizione necessaria per un cambio di regime indotto dall’esterno. Senza una defezione massiccia dei militari, qualsiasi governo imposto dall’esterno sarebbe intrinsecamente instabile.
In secondo luogo, il chavismo non è riducibile a Maduro. È un blocco politico-sociale che affonda le sue radici in una memoria storica anti-imperialista, nella redistribuzione delle rendite petrolifere e in una narrazione di sovranità nazionale che continua a parlare a settori popolari reali, non immaginari. Anche indebolito, questo blocco è in grado di produrre resistenza, adattamento e, se necessario, riorganizzazione.
Per questo la distruzione del Venezuela, se avverrà, non potrà che essere un processo lungo di logoramento, fatto di impoverimento, migrazione di massa, deterioramento dei servizi e normalizzazione del caos. Non un atto spettacolare, ma una lenta erosione.
I limiti dell’intervento statunitense
Qui emerge un punto spesso rimosso dal discorso pubblico occidentale: gli Stati Uniti non sono più l’impero del 1991. Ogni intervento prolungato oggi comporta costi politici, economici e reputazionali enormi. Iraq, Afghanistan e Libia non sono eccezioni: sono precedenti che pesano come macigni.
Un’occupazione diretta del Venezuela sarebbe logisticamente complessa, politicamente esplosiva in America Latina e geopoliticamente provocatoria nei confronti di Russia e Cina. Anche un controllo indiretto tramite un governo fantoccio richiederebbe una stabilizzazione economica che Washington, da sola, difficilmente potrebbe garantire senza reintegrare il Paese nei circuiti globali a condizioni negoziate.
In altre parole: gli USA possono destabilizzare, ma faticano sempre più a governare le conseguenze della destabilizzazione.
Resilienza autoritaria e integrazione multipolare
Uno degli scenari più realistici, nel medio periodo, è la prosecuzione di una forma di resilienza autoritaria: un sistema politico che sopravvive senza risolvere le proprie contraddizioni interne, compensando il consenso con il controllo e l’alleanza con potenze extra-occidentali. Russia, Cina, Iran e – in misura diversa – Cuba non intervengono per ideologia, ma per interesse strategico: energia, posizionamento regionale, rottura dell’unilateralismo statunitense.
Questo non significa prosperità per il Venezuela, né emancipazione sociale. Significa sopravvivenza. E, sul piano geopolitico, significa una cosa molto chiara: il fallimento dell’obiettivo statunitense di riportare il Paese sotto un controllo pieno e incontestato.
La transizione negoziata: possibile ma fragile
Esiste anche l’ipotesi di una transizione negoziata, favorita da attori regionali e internazionali, che preveda un allentamento delle sanzioni in cambio di riforme politiche ed elezioni controllate. È uno scenario teoricamente razionale, ma politicamente fragile. Richiederebbe garanzie reciproche che nessuna delle parti si fida davvero di concedere: Caracas teme la vendetta post-transizione; Washington teme il precedente di una resa negoziale a un governo demonizzato per anni.
Il Venezuela non è invulnerabile, ma non è nemmeno una preda facile. Distruggerlo completamente significherebbe accettare anni di instabilità regionale, un ulteriore indebolimento del diritto internazionale e un’accelerazione della frattura tra Occidente e resto del mondo. Per questo, più che una distruzione totale, è probabile una convivenza conflittuale, fatta di pressione costante, adattamento interno e ridefinizione degli equilibri globali.
In definitiva, il Venezuela non è solo una vittima della storia: è uno dei luoghi in cui si manifesta, in forma concreta, la crisi dell’ordine internazionale costruito dagli Stati Uniti dopo la Guerra fredda. Ed è questo, più del destino di un singolo Paese, il vero nodo in gioco.