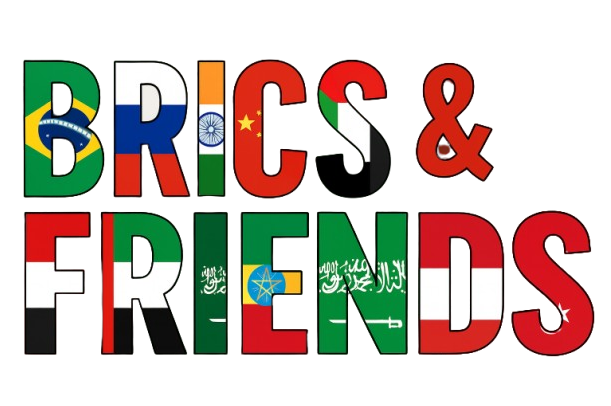Roberto Roggero – Con il colpo di stato americano in Venezuela (perché di questo si è trattato) e con il molto discutibile sequestro di un comunque presidente, pur con i suoi pregi e difetti, atto contrario a ogni principio e diritto internazionale, l’oggetto del contendere, ovvero il petrolio venezuelano (non certo la lotta al narcotraffico…vedi Honduras) balza all’attenzione mondiale.
Il “biondo” Donald si prende il petrolio del Venezuela, che dal punto di vista commerciale non è così conveniente come si potrebbe supporre, o almeno lo potrà essere dopo opportuni trattamenti estremamente dispendiosi, per cui il prezzo sul mercato internazionale potrebbe essere più alto delle normali quotazioni.
Un elemento in particolare penalizza il greggio venezuelano: se dal punto di vista geopolitico e commerciale, e da quello del puro business, le potenzialità sono state accertate (altrimenti non sarebbe stato causa di una crisi come quella in atto), sotto l’aspetto ambientale e climatico, direttamente collegato a estrazione, raffinazione e consumo, sia al dettaglio che soprattutto all’ingrosso, lascia molto a desiderare.
E’ accertato che le riserve del Venezuela sono le più grandi del pianeta, con una stima di molto superiore ai 300 miliardi di barili, ed è stata principalmente questa valutazione, e la vicinanza del Venezuela agli USA, a spingere il “biondo” presidente a osare tanto.
Come termine di paragone, l’Arabia Saudita ha riserve stimate poco meno di 280 miliardi di barili, l’Iran di circa 210 miliardi di barili, l’Iraq 145 miliardi, gli Emirati Arabi 113 miliardi di barili, il Kuwait poco più di 100 miliardi di barili, e gli Stati Uniti non superano i 45 miliardi di barili, ragione base dell’aggressione americana a Caracas.
Il problema è un altro: secondo le informazioni tecniche, il greggio venezuelano è estremamente denso, in gergo è un petrolio “extra-pesante”, oltre 10mila volte più denso dell’acqua, soprattutto quello presente nelle riserve della zona del fiume Orinoco, territorio la cui superficie supera i 55mila km quadrati. Un petrolio diametralmente opposto, come caratteristiche chimiche, a quello utilizzato negli Stati Uniti, e molto più simile al greggio canadese delle cosiddette “Tar Sands”, nello stato dell’Alberta. Ma non è tutto, perché la profondità in ci si trovano le riserve venezuelane, che sono oltretutto anche estremamente vischiose, si aggira intorno ai 1.000 metri. Per rendere l’idea, è molto simile, come consistenza, alla melassa.
Queste caratteristiche lo rendono molto difficile da raggiungere e da estrarre, e non trasportabile attraverso i consueti oleodotti se non diluito con altro petrolio più leggero o altri prodotti per la raffinazione, come la nafta, che deve essere importata dall’Europa, oppure lavorato con complicati procedimenti, in appositi impianti e trasformato in petrolio sintetico. Inoltre, le emissioni di CO2 che questi processi chimici comportano, sono di circa cinque volte superiori in confronto al petrolio abitualmente trattato, come quello dei Paesi del Golfo o della Russia.
I costi di questi processi, per altro necessari, sono estremamente alti, ed è per questo motivo che le esportazioni di greggio venezuelano negli Stati Uniti, durante il periodo Chavez, hanno subito un crollo in seguito al raggelamento dei rapporti commerciali Caracas-Washington.
La produzione venezuelana al momento è ancora in stallo proprio per questi motivi, e se mai dovesse riprendere a ritmi sostenuti, secondo i programmi del “biondo” presidente americano, ne deriverebbe un enorme impatto ambientale poiché l’estrazione del greggio venezuelano richiede smisurate quantità di energia, con conseguente emissione di gas serra che, come sopra detto sono cinque volte superiori alla lavorazione convenzionale, al ritmo di circa 550 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno, cioè quasi due volte il totale rilasciato annualmente nell’atmosfera da un Paese vasto come l’Italia. In numeri, la lavorazione di 500mila barili al giorno si traduce in 182 milioni di barili ogni anno, il che, se solo fosse estratto e lavorato il 10% delle riserve venezuelane, ovvero 30 miliardi di barili, il tempo necessario sarebbe di almeno 160 anni, con un rilascio di quasi 100 miliardi di tonnellate di CO2, con la caratteristica negativa di emissioni pari a circa l’85% di quelle del carbone, fonte fossile più inquinante in assoluto.
Il tutto a estremo danno degli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi sul Clima, cioè il mantenimento dell’aumento delle temperature al di sotto dei 2°C. in questo quadro, attualmente, il ritmo delle emissioni di CO2 si aggirano intorno ai 43 miliardi di tonnellate all’anno
In conclusione, il petrolio del Venezuela porterebbe pericolosamente vicino allo sforamento degli obiettivi previsti per limitare i danni del cambiamento climatico, che in ogni caso, ai ritmi attuali difficilmente saranno comunque raggiunti, ma sarebbe il colpo di grazia finale che darebbe la certezza circa il superamento del punto di non-ritorno per le condizioni del pianeta, perché l’aumento delle temperature globali supererebbe i 2,5°C.
Il petrolio del Venezuela darebbe un fatale impulso al riscaldamento globale, le cui conseguenze sarebbero una incontrollata fusione delle calotte polari, innalzamento dei mari, alterazione degli ecosistemi, inondazione delle fasce costiere, sparizione di molti arcipelaghi specie nell’Oceano Pacifico, migrazioni di massa, incalcolabili perdite economiche di moltissimi Paesi, eventi meteorologici estremi, e altro ancora.
Il problema principale, a monte di tutto questo, è che evidentemente al “biondo” Donald tutto questo sembra essere un trascurabile danno collaterale…